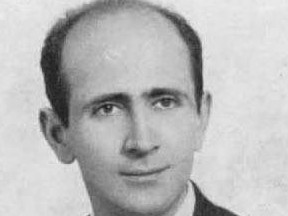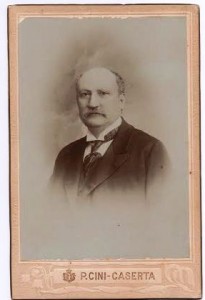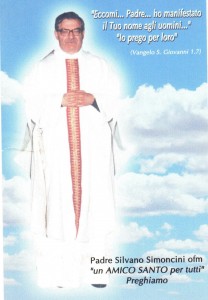Elenco Sindaci ed Eletti dal Sec. XVI ( in aggiornamento) 1506, Eletti: Antonello Fulgo, Joanne Felace, notaro Matteo Votromino e Cicho de Anna. 1507, Sindaco: Juliano Carichya, Eletti: Fabritio Imbriaco, Joanne, Ferraro, Altobello Suoene, Bello Viciglione,Gra no Farina, Nardello Savalone; 1508, Sindaco: Cola Francesco deli Caprii; 1512, Eletti: mastro Alfonso de Leticia, Francesco de Basta, Alfonso de Novella e Cesare Noczione; 1516, Eletto: mastro Fonso de Leticia. 1517, Eletti: Fonse de Leticia, Nardo Pellegrino, Alfonso Peticto, Antonello Viciglione, Jesomin de Montone, Joanne Pellegrino, Lionecta Covelluczo e Perrillo de Anna. 1521, Eletti: Antonio de Colino, Oliviero de Cionto, Auditore agli Eletti, Giacomo de Caprio, Alfonso Soene, Francesco de Benedicto di Capiterise, Micco Paccone, Samo de Anna. 1527, Sindaco: Nicola Veceglione,Eletti: Dominico dela Gamba, Antonio Veceglione, Dominico Foglia, Joanne Felace. 1528, Eletto di Mse: Antonio de Galluccio. 1532, Eletti: Petro de Maffeo, Cola Gaglione, Galiecta, Joanne Morrone e Jordano Savalone. 1546, Eletto: Lonardo Foglia. 1547, Eletto: Notaro Salvatore Nuczione. 1556,
no Farina, Nardello Savalone; 1508, Sindaco: Cola Francesco deli Caprii; 1512, Eletti: mastro Alfonso de Leticia, Francesco de Basta, Alfonso de Novella e Cesare Noczione; 1516, Eletto: mastro Fonso de Leticia. 1517, Eletti: Fonse de Leticia, Nardo Pellegrino, Alfonso Peticto, Antonello Viciglione, Jesomin de Montone, Joanne Pellegrino, Lionecta Covelluczo e Perrillo de Anna. 1521, Eletti: Antonio de Colino, Oliviero de Cionto, Auditore agli Eletti, Giacomo de Caprio, Alfonso Soene, Francesco de Benedicto di Capiterise, Micco Paccone, Samo de Anna. 1527, Sindaco: Nicola Veceglione,Eletti: Dominico dela Gamba, Antonio Veceglione, Dominico Foglia, Joanne Felace. 1528, Eletto di Mse: Antonio de Galluccio. 1532, Eletti: Petro de Maffeo, Cola Gaglione, Galiecta, Joanne Morrone e Jordano Savalone. 1546, Eletto: Lonardo Foglia. 1547, Eletto: Notaro Salvatore Nuczione. 1556,